Bambini connessi, adulti distratti: l’infanzia rubata dagli schermi
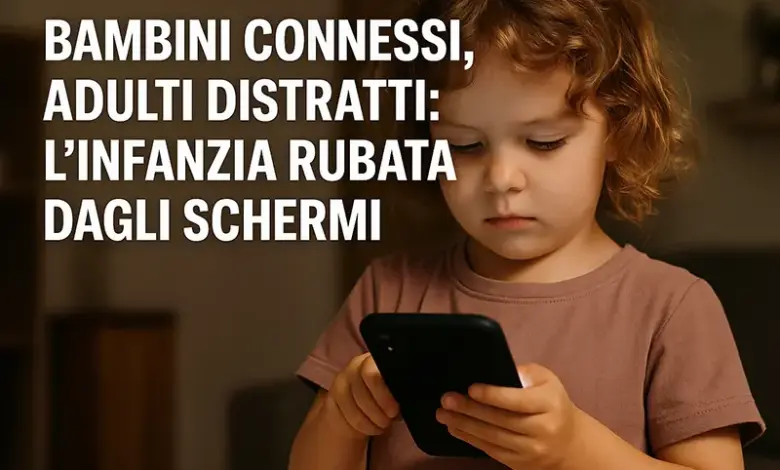
Quando mia figlia aveva meno di un anno, la portavo in piscina per i primi corsi neonatali. Ricordo ancora la scena che si ripeteva tutte le domeniche negli spogliatoi: mentre la tenevo in braccio per asciugarle i capelli e cambiarla, osservavo altri genitori posare il tablet o lo smartphone davanti ai loro bambini, anche piccolissimi, per tenerli “buoni” e “gestirli” con la massima “comodità”. Quei bimbi sembravano tanti bambolotti spenti con gli sguardi persi negli schermi. 10 anni fa mi sembrava un’anomalia. Oggi, mi dicono, è la normalità.
Purtroppo, i numeri lo confermano: secondo il nuovo rapporto OCSE “How’s Life for Children in the Digital Age?”, il 70% dei bambini di 10 anni ha già uno smartphone. Entro i 15 anni, il 98% degli adolescenti nei Paesi OCSE naviga in rete quotidianamente tramite il proprio dispositivo personale.
Il 70% dei bambini di 10 anni ha già uno smartphone
Ma cosa comporta tutto questo? Siamo davvero pronti a crescere una generazione che trascorre più tempo davanti a uno schermo che all’aria aperta? E soprattutto: stiamo capendo fino in fondo cosa significa “benessere digitale”?
Parliamo di dati
Lo studio OCSE fotografa una situazione ormai diffusa e trasversale: l’accesso al digitale è praticamente universale tra gli adolescenti. Il problema non è tanto se i bambini usano i dispositivi digitali, ma come, quanto e con quali conseguenze.
Nel 2022, almeno il 50% dei quindicenni nei Paesi OCSE ha trascorso 30 o più ore a settimana davanti a schermi
Nel 2022, almeno il 50% dei quindicenni nei Paesi OCSE ha trascorso 30 o più ore a settimana davanti a schermi. In Lettonia, il 43% supera addirittura le 60 ore settimanali. E non parliamo solo di didattica a distanza: la maggior parte di queste ore è dedicata ad attività ricreative come social network, video, gaming e messaggistica.
Se da un lato questi strumenti offrono opportunità incredibili — apprendimento, creatività, connessione sociale — dall’altro il report sottolinea i rischi legati a un uso intensivo e incontrollato: disturbi del sonno, ansia, depressione, isolamento sociale, problematiche legate all’immagine corporea.
Il paradosso educativo
Quante volte ci capita di vedere bambini piccolissimi lasciati in balia di un tablet al ristorante mentre i genitori cenano tranquilli? È una scena così frequente che ormai non ci facciamo più caso. Ma ciò che normalizziamo può diventare strutturale.
Il rapporto OCSE invita a riflettere su un paradosso: da un lato, i bambini chiedono protezione e guida nel mondo digitale; dall’altro, gli adulti — spesso inconsapevoli o impreparati — li lasciano soli, privi di regole chiare e strumenti critici.
Il carico educativo ricade tutto su genitori e insegnanti, ma senza un’adeguata formazione o indicazioni pratiche, il rischio è quello di navigare a vista. L’OCSE suggerisce approcci più sistemici: serve una strategia coordinata tra scuole, famiglie, istituzioni e aziende tech.
Il ruolo della scuola
Uno degli aspetti più urgenti è il rafforzamento delle competenze digitali e del pensiero critico a scuola. I dati dimostrano che un utilizzo attivo e consapevole della tecnologia può migliorare il benessere: per esempio, l’uso creativo dei media (montaggio video, coding, storytelling digitale) è associato a esiti positivi, mentre il consumo passivo (scroll infinito, binge watching) è spesso correlato a esiti negativi.
Per questo motivo, il report suggerisce che siano proprio le scuole a diventare “hub” dell’educazione digitale, promuovendo l’alfabetizzazione mediatica e la capacità di autoregolazione.
Genitori disorientati
Un’altra raccomandazione cruciale riguarda il supporto ai genitori. Le famiglie sono spesso lasciate sole nel definire regole e limiti, in un contesto in cui anche i bambini di due anni iniziano a usare schermi touch.
Molte famiglie optano per il “divieto secco”, ma questa strategia si dimostra inefficace e potenzialmente controproducente.
Molte famiglie optano per il “divieto secco”, ma questa strategia si dimostra inefficace e potenzialmente controproducente. Il digitale è ormai parte integrante dell’identità dei giovani: escluderli significa rischiare isolamento sociale. L’alternativa è una mediazione attiva, fatta di ascolto, accompagnamento e dialogo continuo.
La vulnerabilità dei più fragili
Il report mette in evidenza che non tutti i bambini sono uguali di fronte al digitale. I più vulnerabili — bambini con difficoltà scolastiche, problemi familiari, bassa autostima — sono anche quelli più esposti ai rischi online: cyberbullismo, dipendenza, disinformazione, disturbi emotivi.
In questi casi, l’ambiente offline (famiglia, scuola, comunità) gioca un ruolo cruciale: può essere un fattore di protezione o un moltiplicatore di rischio. Ecco perché le politiche pubbliche devono tenere conto del contesto socioeconomico, culturale ed educativo in cui i ragazzi vivono.
Tecnologie emergenti e nuovi rischi
L’arrivo di intelligenza artificiale generativa, realtà virtuale e ambienti immersivi aggiunge nuove complessità. Da un lato, queste tecnologie possono potenziare l’apprendimento e offrire strumenti terapeutici innovativi. Dall’altro, pongono interrogativi etici e psicologici non trascurabili: confusione tra reale e virtuale, dipendenza, distorsione della percezione del sé.
Il report invita a progettare tecnologie “safe by design”, ovvero con meccanismi integrati per la tutela dei minori fin dalla fase di sviluppo dei prodotti.
I problemi di un’esposizione eccessiva
1. Disturbi del sonno
L’esposizione prolungata agli schermi, soprattutto nelle ore serali, altera i ritmi circadiani e riduce la qualità e la quantità del sonno. Questo impatto è particolarmente critico per i bambini, la cui salute mentale e sviluppo cognitivo dipendono fortemente da un riposo adeguato.
2. Ansia e depressione
Un uso intensivo dei social media e dei contenuti digitali può aumentare i livelli di ansia, sintomi depressivi e sensazioni di inadeguatezza, soprattutto nei preadolescenti. Il confronto costante con modelli irrealistici contribuisce a una bassa autostima e a disturbi dell’immagine corporea.
3. Riduzione dell’attività fisica
Il tempo trascorso davanti allo schermo spesso sostituisce il gioco attivo all’aperto, con conseguenze sullo sviluppo motorio e sulla salute generale dei bambini. Ciò è associato anche a un aumento dell’obesità infantile e a problemi posturali.
4. Problemi di concentrazione e rendimento scolastico
L’uso eccessivo di smartphone può ridurre la capacità di concentrazione e la memoria a breve termine, interferendo con l’apprendimento e il rendimento scolastico. La presenza costante di notifiche e distrazioni digitali ostacola la capacità dei bambini di restare focalizzati.
5. Isolamento sociale
Sebbene i dispositivi digitali offrano connessione e comunicazione, un uso non regolato può portare a una progressiva perdita delle interazioni faccia a faccia. Questo compromette lo sviluppo di competenze sociali e relazionali fondamentali.
6. Esposizione a contenuti inappropriati e cyberbullismo
I bambini con accesso illimitato alla rete sono più vulnerabili a contenuti dannosi e violenti, così come a fenomeni di cyberbullismo, che possono lasciare cicatrici emotive profonde.
La necessità di un nuovo patto educativo
A livello di policy, il messaggio dell’OCSE è chiaro: serve un approccio olistico, basato su quattro pilastri:
-
Regolamentazioni efficaci e tecnologie progettate per la sicurezza dei bambini.
-
Promozione di competenze digitali, con un ruolo centrale delle scuole.
-
Supporto pratico a genitori e caregiver.
-
Inclusione delle opinioni e dei bisogni dei bambini stessi nella definizione delle politiche.
Ma quindi, cosa facciamo?
La domanda non è più “se” il digitale faccia parte della crescita dei nostri figli, ma “come” possiamo accompagnarli in questo percorso senza lasciarli soli. La tecnologia non è il nemico, ma lo diventa se affidata all’anarchia educativa.
La domanda non è più “se” il digitale faccia parte della crescita dei nostri figli, ma “come” possiamo accompagnarli in questo percorso senza lasciarli soli.
Come genitori, insegnanti, imprenditori e cittadini, abbiamo la responsabilità di ridisegnare questo ecosistema, rendendolo più umano, empatico e sostenibile. Perché ogni swipe, ogni clic, ogni video visto su uno smartphone è un tassello dell’identità futura dei nostri figli.
E se vogliamo che siano adulti consapevoli, critici e liberi, dobbiamo iniziare oggi a educarli non solo all’uso della tecnologia, ma alla comprensione profonda del suo impatto sulla loro vita.
Fonte:
OECD (2025), How’s Life for Children in the Digital Age?, OECD Publishing, Paris.







